A Personal Journey Through Martin Scorsese’s Movies parte II
Parte II “Gli anni ’70″
E’ arrivato il momento di ritornare con prepotenza ai temi che più gli sono vicini.
A trentaquattro anni, giunto al quinto lungometraggio, gira uno dei vertici assoluti della sua carriera e del cinema americano del decennio e non solo: è la consacrazione, è “Taxi Driver”.
 “Io ho scritto una sceneggiatura essenzialmente protestante e Marty ha diretto un film molto cattolico”.
“Io ho scritto una sceneggiatura essenzialmente protestante e Marty ha diretto un film molto cattolico”.
Così Paul Schrader, lo sceneggiatore di “Taxi Driver” (1976); presenta il quinto lungometraggio del regista.
Il film che lancia definitivamente Scorsese come uno dei principali autori del suo tempo e gli dà la fama nasce infatti da uno sceneggiatura originale.
Se Martin ha un forte retroterra religioso, Schrader viene da un’infanzia e una gioventù segnate da un’impostazione osservante ancora più rigorosa.
Nato nel ’46 cresce con un padre deciso a fare dei figli dei ministri religiosi e infatti studia in seminario.
Qualche anno prima aveva pubblicato un saggio fondamentale di critica: “Lo stile trascendentale nel film- Ozu, Bresson, Dreyer” e nella futura carriera firmerà altri film importanti prima di passare alla regia (“Hardcore”, “Il bacio della pantera”,”The Affliction”).
Schrader tornerà a lavorare con Scorsese altre tre volte: “Toro Scatenato”, “L’ultima tentazione di Cristo” e “Al di là della vita”.
La sceneggiatura mescola ossessioni religiose, echi della letteratura esistenzialista e autobiografia.
In un periodo di crisi, non riuscendo a dormire, si trova a passare le notti bevendo, girando in auto la notte e guardando film porno. E da qui gli viene l’idea. Comincia a scrivere ed ecco pronto Travis Bickle.
Trova il suo personaggio, la sua metafora: “Un’automobile come simbolo della solitudine urbana, una bara metallica”.
Al resto ci pensa Marty, la sceneggiatura si adatta perfettamente alla sua poetica e alla sua interpretazione.
Il terzo fondamentale apporto lo dà De Niro.
Impegnato parallelamente a migliaia di chilometri per le riprese di “Novecento” di Bertolucci, De Niro realizza una straordinaria prova d’attore che lo impone come uno dei grandi interpreti del suo tempo. Da questo momento il rapporto col regista si farà strettissimo: il risultato sono altri sei film.
“Taxi Driver” deve la sua perfezione anche alla sintonia e bravura dei tre, senza sottovalutare gli altri aspetti tecnici che contribuiscono notevolmente all’eccezionale qualità del risultato: la fotografia di Michael Chapman o la musica del grande Bernard Hermann, compositore della colonna sonora di “Quarto Potere” e autore prediletto di Hitchcock, che muore prima che il film esca nelle sale.
 A parte i presupposti, il film è un capolavoro: seguendo il protagonista nei giri notturni, immergendosi nella sua follia e partecipando al climax di violenza fino alla carneficina finale lo spettatore è proiettato in un mondo di oscurità, disperazione e morte, che raramente il cinema è stato capace di descrivere con così perfetta precisione.
A parte i presupposti, il film è un capolavoro: seguendo il protagonista nei giri notturni, immergendosi nella sua follia e partecipando al climax di violenza fino alla carneficina finale lo spettatore è proiettato in un mondo di oscurità, disperazione e morte, che raramente il cinema è stato capace di descrivere con così perfetta precisione.
Difficile trovare un così potente affresco che metta a nudo il lato più oscuro, non solo della società americana, ma dell’uomo in generale, che scavi con tale decisione nelle viscere del cuore di tenebra del nostro tempo, che parli con tale intensità della solitudine e della violenza metropolitana.
Difficile, anche, trovare un film che in poco tempo entri con tale prepotenza nell’iconografia contemporanea (quante volte si è vista una citazione della scena con De Niro che fa le prove allo specchio?).
Assorbite e assimilate tradizione europea, cinema americano classico e rotture delle nouvelle vague, Scorsese ha uno stile assolutamente personale e maturo, che convince critica e pubblico, situazione che spesso si è ripetuta nella sua successiva filmografia.
Il Film è Palma d’oro al Festival di Cannes del 1976.
È il primo riconoscimento internazionale che il giovane regista vince.
Robert De Niro aveva già lavorato con Scorsese, ma è con “Taxi Driver” che il rapporto diventa stretto, consolidandosi ancora di più con il film successivo: “New York, New York” (1977).
Come già dopo “Mean Streets” il film segna un bello scarto dall’opera precedente: raccontando la vicenda di un sassofonista e una cantante che girano l’America suonando nelle grandi big band di jazz nell’immediato dopoguerra, intrecciando la loro vicenda amorosa con quella artistica, il regista cambia ancora una volta le carte in tavola.
L’immediato riferimento è al musical anni ’40-’50, ma l’omaggio è a tutto il cinema americano del periodo.
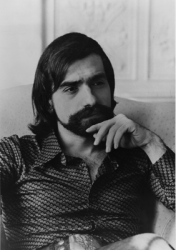 Girando interamente in teatro di posa, ventidue settimane senza locations, il regista dimostra una versatilità sorprendente col venir meno ad una delle sue caratteristiche più macroscopiche, quella appunto di girare in ambienti reali, seguendo i dettami del nuovo cinema.
Girando interamente in teatro di posa, ventidue settimane senza locations, il regista dimostra una versatilità sorprendente col venir meno ad una delle sue caratteristiche più macroscopiche, quella appunto di girare in ambienti reali, seguendo i dettami del nuovo cinema.
Una scelta radicale che presuppone un approccio antitetico rispetto all’immediatezza, al realismo estremo che gli avevano dato la fama.
Il film così apparentemente diverso dai precedenti è la dimostrazione di quanto sia maturo il regista: ha uno stile così personale da potersi confrontare con un linguaggio opposto, senza perdere nulla di sé, una vera sfida.
“A livello di decoupage, ho sovente adottato lo stile dell’epoca: campi medi, piani americani, piani ravvicinati, primi piani di una medesima scena. Quando sorgeva una difficoltà, mi rifacevo alla buona vecchia “grammatica cinematografica d’altri tempi”.
Non un esercizio di stile, ma una sfida, un mettersi in gioco, anche un divertimento: “Tutto sommato mi sono divertito, avvicinandomi all’omaggio verso un tipo di cinema di cui in passato si è abusato ma di cui bisogna tener conto”.
E, non dimentichiamolo, un ennesimo atto d’amore per il cinema.
Anche quello da cui Marty sembra più distante.
Le riprese di “New York, New York” si concludono nel novembre del ’76.
Nello stesso periodo, il 25, si tiene a San Francisco il concerto d’addio di uno dei gruppi simbolo del rock (inteso come controcultura) americano: The Band.
Il concerto non sancisce solo la fine di un gruppo, ma si trasforma nel saluto, l’elegia finale per tutta un’epoca e sono in tanti a parteciparvi (Neil Young, Joni Mitchell, Muddy Waters, Bob Dylan e il poeta beat Ferlinghetti per dirne alcuni).
Martin, la cui passione per il rock è risaputa, decide di riprendere la serata.
[img4]Il risultato sarà “The Last Waltz” (1978): ennesima dimostrazione della poliedricità dell’artista, che così lo presenta: “New York era la musica di mio padre; The Last Waltz è la mia. E non credo che questo concerto sia una fine. La fine di un’epoca forse, ma non quella del rock. The Last Waltz non è un’elegia. Non c’è tristezza”.
Non routine: è artista completo e formato e la sua personalità si impone sempre.
Se all’epoca il concerto filmato è un genere codificato, Scorsese lo reinventa: rinuncia a riprendere il pubblico, concentrandosi solo sugli artisti che si esibiscono, per cogliere l’emozione e l’intensità che si crea sul palco.
“Questo film è l’occasione per me di esprimere i miei sentimenti verso la musica che, all’infuori delle donne e del cinema, è ciò che conta di più per me. Non ho voluto realizzare un film musicale classico. Ciò che mi interessava era descrivere l’intensità che regna tra i musicisti e non le reazioni del pubblico”.
Si può tranquillamente dire che ci è riuscito, creando uno dei migliori documentari rock di sempre.
Con “The Last Waltz” si chiudono gli anni ’70 per il regista, che si affaccia puntuale nel nuovo decennio con l’ennesimo capolavoro: “Toro Scatenato”.
… Continua
Scrivi la tua opinione sul forum
A cura di
approfondimenti ::