A Personal Journey Through Martin Scorsese’s Movies parte I
Parte I “Due decenni: ’60, ’70″
Cap.1: “Primi passi, primi film”
“Quando si è stati allevati a Little Italy, che cosa diventare se non gangster o prete? Ora io non potevo essere né l’uno né l’altro. Fisicamente, non potevo rappresentare un gangster accettabile.”
Per fortuna nostra, di strada ne aveva un’altra. Così, quando nel 1962 la sua domanda di ammissione al collegio dei gesuiti è respinta, si orienta verso la New York University, dove può approfondire la sua passione primaria: il cinema. Grazie proprio ai corsi di H.P. Manoogian scopre la sua strada, la sua vocazione. Che non è quella religiosa.
Nato nel 1942 a Flushing, si trasferisce a Little Italy nel 1950.
Appartiene alla terza generazione di immigrati. I nonni hanno abbandonato l’Italia quarant’anni prima e non impareranno mai l’inglese. Cresce in un ambiente religiosissimo e da bambino sviluppa una vocazione al sacerdozio, scelta di cui entrambi genitori (impiegati in una fabbrica di vestiti) sono molto fieri. Il padre è responsabile dell’altra grande passione. Fisicamente gracile, il ragazzo non può intraprendere la carriera sportiva desiderata per lui. Il padre in compenso lo porta al cinema. Due, tre volte alla settimana.
Una vera e propria indigestione che stimola enormemente la fantasia del bambino. Vede tutto, ma è colpito in particolare dai kolossal: “La Tunica”, “Quo Vadis”, “I Dieci Comandamenti ( “L’ho visto quaranta, cinquanta volte”); e “La Regina delle Piramidi”, che divenne il suo preferito. Quando non è al cinema, a casa si crea dei propri film, disegnandosi delle story-board. La condizione economica non permette a Martin di poter possedere una super8 ( come invece potrà Spielberg) e si deve accontentare di un sostituto più artigianale. Anche a casa ha modo di coltivare la sua passione: è nella piccola televisione di famiglia che vede i primi film europei, come “Roma città aperta “o “Paisà” che segue con i nonni in lacrime, commossi nel sentire il dialetto di casa e nel vedere panoramiche della loro terra. Finalmente all’università la vocazione diventa realtà. Manoogian, oltre ad essere un docente illuminato, stimola e spinge i suoi allievi a girare dei corti. Scorsese appena ne ha le possibilità non si tira indietro. Nel 1963 gira il suo primo cortometraggio: “What’s a nice girl like you doing in a place like this?” , che è Scorsese stesso a presentare: “La storia non aveva né capo, né coda. Era paranoia pura. Nove minuti di nonsense visivo con la voce del narratore da cima a fondo”. Si ritrovano gli omaggi a Truffaut l’afffinità al nuovo umorismo Usa televisivo e qualche elemento della sua tecnica matura (la voce narrante). Il corto, pur senza una vera e propria trama (l’idea è quella di un uomo che entra in un quadro) riscuote un certo successo e qualche mese dopo può realizzare un’opera più impegantaiva. “It’s Not Just you, Murray” sviluppa temi cari poi al regista. Raccontando in 15 minuti la storia di due gangster e della fidanzata di uno dei due, Scorsese ha modo di girare nel suo quartiere, come farà anni dopo in “Mean Streets”… Anche in questa opera si concede di omaggiare altri maestri: la nouvelle vague di Truffaut e Godard, il movimento centrale di quel periodo, ma anche il Fellini di “8 1/2″( che lo stesso regista indica come uno dei film della sua vita) di cui riprende il famoso girotondo finale. Nel 1965, grazie all’aiuto di Manoogian, riesce a girare il suo primo lungometraggio, ma le reazioni negative lo spingono a mettere da parte il film e a tornare al cortometraggio. Nel 1967 gira il suo terzo e ultimo corto. Il primo a colori, il più breve ma il più significativo. Un opera più matura che avrà grande risonanza. “The Big Shave” ha una trama semplicissima: un bagno perfetto e immacolato, un uomo che si rade. Una volta, due, tre, fino a che il viso è una maschera di sangue. A quel punto si taglia la gola.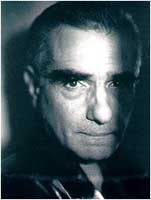
Un breve incubo americano, un attacco violento alla normalità borghese, nel periodo in cui l’America è sconvolta e lacerata dal Viet-Nam.
Scorsese dirà: “Di fatto, “The Big Shave” era un fantasma, una visione strettamente personale della morte”.
Sicuramente, ma non solo.
Girato perfettamente, una fotografia gelida dai colori abbaglianti, un montaggio vicino alla scuola sovietica degli anni ’20, la novità è anche nel sonoro. Tutta l’azione è accompagnata da una canzone del ’39, la cui dolcezza crea un contrasto violentissimo nell’accostamento con immagini al limite dello splatter. Il sangue invade copiosamente l’ambiente più intimo, un gesto tra i più quotidiani diventa allucinante orrore. C’è tutta la tragedia che in quegli anni divide l’America.
È il sogno americano che si rivela, incubo.
Una straordinaria metafora della fine del sogno americano. La menzogna della perfezione dell’american way of life, dove tutto è piacevole e sereno, l’ideale di vita che vent’anni di propaganda avevano cercato di inculcare con ogni mezzo necessario si frantuma con violenza, proprio in quegli anni, grazie anche alle opere di Scorsese e di altri registi suoi coetanei.
Nello stesso periodo Scorsese riprende in mano il suo primo lungometraggio: gira nuove scene (con Harvey Keitel); rimonta il materiale e presenta l’opera al festival del cinema di Chicago. È un nuovo insuccesso. Scoraggiato, Martin decide di lasciare gli Stati Uniti. Gira degli spot ad Amsterdam e partecipa come co-sceneggiatore a un thriller tedesco. Improvvisamente, un colpo di fortuna. Manoogian lo chiama e gli comunica che ha trovato una distribuzione per il film.
Tornato in Usa, gira nuove scene e il film esce nel ’69, a quattro anni dalla sua ideazione. “Who’s that knocking at my door” , che descrive la vita quotidiana di un ragazzo (Harvey Keitel) a Little Italy, vicino, formalmente, a Godard e compagni, risente anche della lezione del più importante regista indipendente Usa, John Cassavetes. È la stessa opera prima di Cassavetes ad essere citata da Diane Jacobs : “come Shadows, il film è più passionale che intellettuale”, giudizio che riassume l’atteggiamento di molti critici (Sarris, Crist) che lo vedono sincero, emotivo e irrazionale.
Marty non si ferma: sempre nel ’69, collabora con l’amico M. Wadleigh sul set di “Woodstock”, in qualità di aiuto-regista e soprattutto di montatore. Al 1970 risale l’unica esperienza di cinema militante del nostro. All’epoca il movimento studentesco viveva il suo periodo di maggior intensità e Scorsese decide di riprendere, con le attrezzature dell’università, le manifestazioni, per montarle in un documentario dal titolo “Street Scenes” . Ma non fu un gran successo: “Quando lo proiettai ai partecipanti, lo rifiutarono: non lo trovarono abbastanza contestatario. Si sentivano traditi, non si riconoscevano. Eppure credo che il quadro fosse abbastanza onesto: mostravo la triste realtà, la collera, la frustrazione, l’irresponsabilità, il generale sentimento di impotenza.”.
Come altri della sua generazione, anche Scorsese deve il suo vero esordio a Roger Corman. Il regista-produttore aveva visto “Who’s that knocking…” e sapeva che aveva lavorato a Woodstock. Così gli offre di girare un film dall’autobiografia di Bertha Thompson. Chiaramente il budget è limitato, ma il giovane regista riesce a girare il tutto in 24 giorni. “Boxcar Bertha” (“America 1929: sterminateli senza pietà”); racconta le vicende di una ragazza (interpretata da Barbara Hershey, futura Maddalena per il Cristo che Scorsese girerà vent’anni dopo) che si trova a vivere da vagabonda e fuorilegge nella difficile realtà della grande depressione post ’29. Film duro, rivela i temi e la forma della futura carriera del regista. Seppur prodotto da Corman, lo stile è del tutto personale. Non mancano omaggi ad altro cinema (Godard, il King Vidor di “Duello al sole”); ma è già evidente tutto il talento del giovane autore, che crea un film teso e avvincente, in cui la violenza mostra, ancora una volta, l’altra America, lontana dagli stereotipi della propaganda.
Film duro, rivela i temi e la forma della futura carriera del regista. Seppur prodotto da Corman, lo stile è del tutto personale. Non mancano omaggi ad altro cinema (Godard, il King Vidor di “Duello al sole”); ma è già evidente tutto il talento del giovane autore, che crea un film teso e avvincente, in cui la violenza mostra, ancora una volta, l’altra America, lontana dagli stereotipi della propaganda.
Ormai maturo, Scorsese può affrontare il film che si porta dentro da anni: “Mean Streets” . Il film della rivelazione.
Cap. 2: “La consacrazione: le strade oscure di un italoamericano”
“L’assoluzione dei propri peccati non si ottiene in Chiesa, ma per la strada e in noi stessi. Tutto il resto è una balla”.
Con queste parole, pronunciate dal protagonista su schermo nero si apre il terzo lungometraggio di Martin Scorsese, il primo capolavoro, il film fondamentale per la sua carriera: “Mean Streets”. Ora il regista, oltre a mostrare una perfetta padronanza del mezzo tecnico, dimostra di essersi creato uno stile profondo e personale: sarà infatti il film che lo rivela, appena trentenne, al mondo. Maturo, può dimostrare con veemenza di possedere un proprio linguaggio con cui esprimere un’ancor più personale poetica. Dichiara: “Mi sto sforzando di avvicinarmi a un modo di fare cinema dove le cose siano semplici e dirette. Dove io possa raccontare una storia senza che debba essere la più lunga, la più complessa o più tradizionale storia del mondo. “Il Padrino” è un classico film narrativo epico, ma io sto andando nella direzione opposta”. Più che di un giovane regista sembrano le parole di un maestro affermato. L’idea se la portava dentro dal 1966, anno in cui ne firma la prima stesura, ma solo nel ’73 ha la possibilità di girarlo, in ventisette giorni. Forse mai più farà un’opera così sincera e autobiografica: raccontando la vita di due amici ventenni che crescono a Littlle Italy, ha modo non solo di attingere a svariati ricordi della sua vita e a personali esperienze, ma per la prima volta può far prendere corpo, evocare le ossessioni che si porta dentro da sempre e che da questo momento faranno parte di tutte le sue opere future (il peccato e la redenzione, la carne e il sangue). Tutto il film si può vedere come manifestazione delle ossessioni religiose ed esistenziali che lo perseguitano fin dall’infanzia. O anche come il momento in cui l’artista capisce il modo in cui esorcizzarle e superarle: attraverso l’arte appunto.
Maturo tecnicamente, ha la possibilità di sperimentare la tecnica dell’improvvisazione con gli attori (una delle scene fondamentali del film è stata tutta improvvisata dai due protagonisti); grazie anche ai due protagonisti: Harvey Keitel e Robert De Niro. Il film infatti non rivela solo uno straordinario talento dietro alla macchina da presa, ma anche davanti: è il film con cui inizia uno dei più importanti sodalizi del cinema Usa contemporaneo e che lancia uno degli attori più amati e apprezzati da critica e pubblico di questi decenni. De Niro, per l’appunto. Autobiografici si diceva: non è difficile vedere nei due amici protagonisti, due caratteri assolutamente opposti e antitetici , due facce dello stesso Scorsese che, non a caso, interpreta nella scena finale il sicario che uccide Johnny, eliminando la parte più incontrollabile e autodistruttiva del film , ma anche di sé stesso.
Muore Johnny, sopravvive Charlie.
Per il regista si apre una nuova fase, che non si è più chiusa: quella del successo e dell’affermazione. È nato un nuovo autore, che possiede, citando Michael Henry: “una messa in scena fisica, a fior di pelle, senza uguali nel far salire in superficie ciò che in altri resterebbe allo stato latente”.
[img4]
Dopo “Mean Streets” molti sono i copioni sui gangster che vengono proposti al regista. Ma il film seguente sarà lontano dalle atmosfere del precedente: non più carne e sangue, violenza e oscurità ma aria, luce, un viaggio e uno dei ritratti femminili più intensi del cinema Usa degli anni ’70. “Alice non abita più qui” (1974) road movie, dominato dal tema del viaggio, come molti altri film della “nuova Hollywood” del periodo, è realizzato da Scorsese grazie all’aiuto di Coppola, che aveva fatto il suo nome a Ellen Burstyn (protagonista del film) che gli aveva chiesto un giovane regista interessato al copione.
Nel film, in cui si raccontano le vicissitudini di una giovane madre rimasta vedova nelle campagne americane, Scorsese porta al massimo livello la tecnica dell’improvvisazione, messa a punto già in “Mean Streets” e, abbandonata la violenza metropolitana, si confronta con la commedia e il melò alla Douglas Sirk, ovviamente filtrato dalla propria poetica. Questo inaspettato cambio di tono è l’ennesima conferma della maturità del giovane autore.
E della sua versatilità.
Nello stesso periodo in cui monta il film, riesce a realizzare un breve documentario (48 minuti) sui suoi genitori e il mondo di Little Italy.
Commissionatogli per il bicentenario degli Stati Uniti, “Italianamerican” è un film “strano e curioso. Partito per trattare dell’immigrazione, è diventato un film su due persone che hanno vissuto insieme quarant’anni, sui loro rapporti reciproci e con me”, come lo presenta lo stesso autore. Un atto di affetto per il proprio passato, la propria storia, le proprie radici.
… Continua
Scrivi la tua opinione sul forum
A cura di
approfondimenti ::